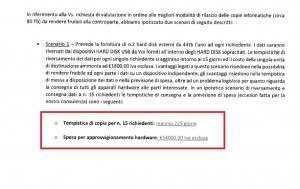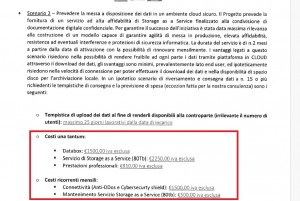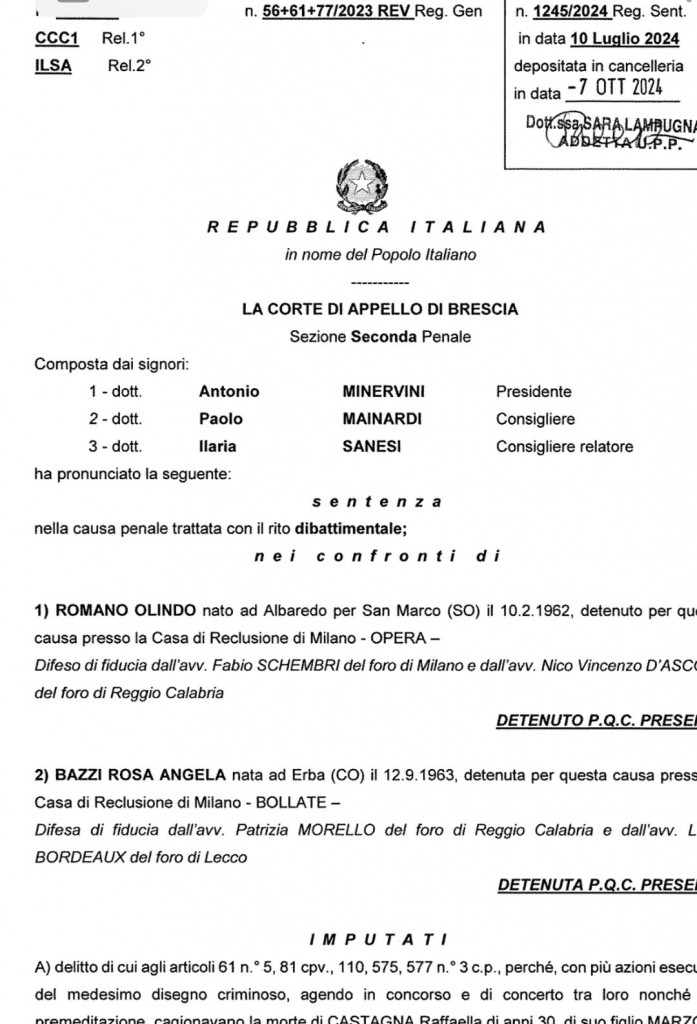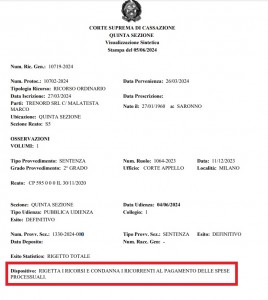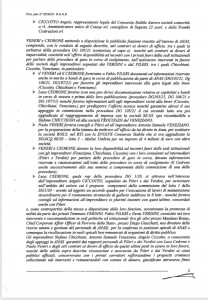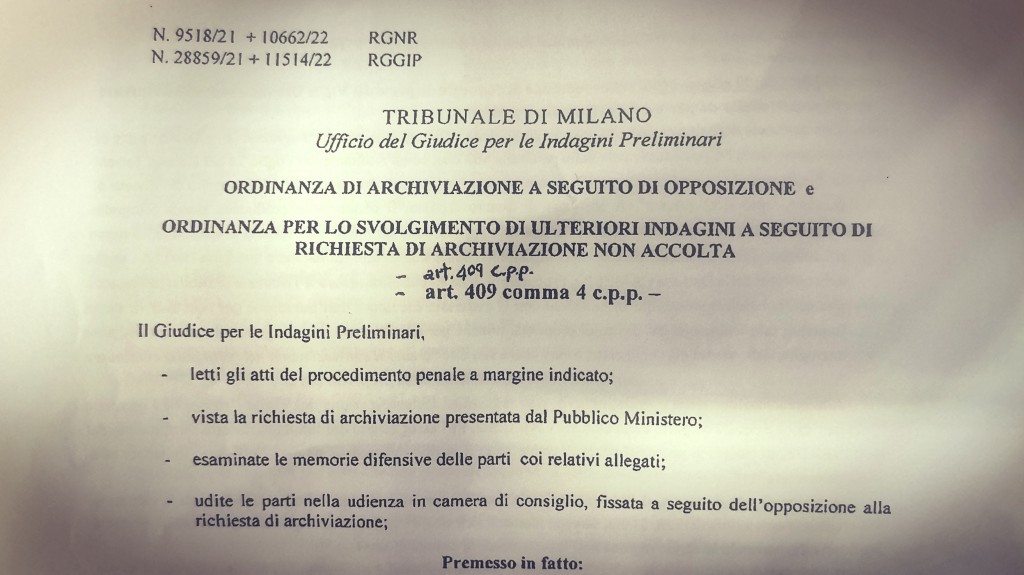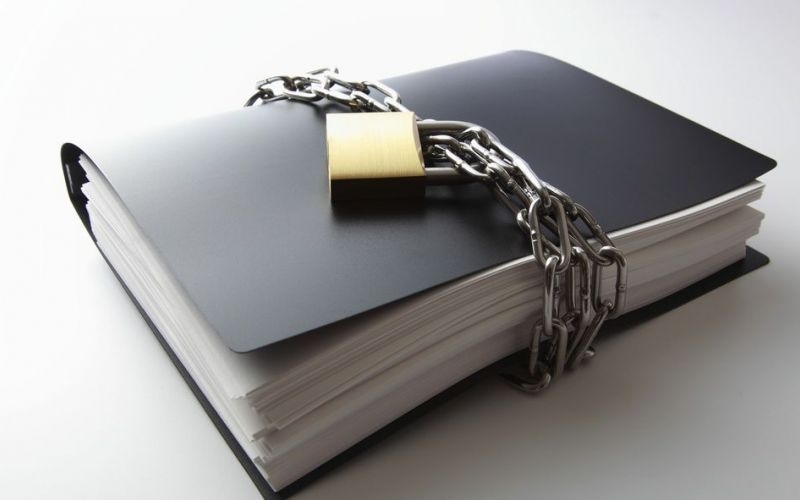Si sono impiccati quasi tutti, chi col laccio dei pantaloni, chi con le lenzuola, chi con una corda. Qualcuno si è soffocato con un sacchetto di plastica, qualche altro riempiendosi i polmoni di gas o altre sostanze. A volte in cella non erano soli, c’erano dei compagni. Sono morti soprattutto di notte e d’estate.
A volte non subito, gli agenti della penitenziaria hanno provato a rianimarli. Età media sui 40 anni, più stranieri che italiani.Reati dall’omicidio al piccolo spaccio, tanti con dipendenza dalla droga, diversi con sofferenze psichiatriche.
Ecco gli 88 uomini e donne che si sono tolti la vita nelle carceri italiani dal primo gennaio 2024. Nel 2022 alla fine se ne erano contati 85, due anni dopo si è andati oltre. Non di tutti sono noti nomi e cognomi, della maggior parte i sindacati penitenziari, che a loro volta registrano sette suicidi di agenti in questo anno, hanno diffuso, assieme ad associazioni, garanti e legali, minimi brandelli delle loro storie.
6 gennaio 2024: Matteo Concetti, 23 anni. Stava male da tempo, soffriva di disturbo bipolare. Era rientrato nel carcere di Ancona perché, svolgendo la pena alternativa lavorando in una pizzeria, aveva sforato sull’orario di rientro a casa. Il 5 gennaio aveva detto alla madre: “Se mi riportano in isolamento, mi ammazzo”
8 gennaio 2024: Stefano Voltolina, 26 anni, detenuto a Padova, soffriva di depressione. Una volontaria ha affidato il suo ricordo a ‘Ristretti orizzonti’: “Era sveglio, buono, curioso. Abbiamo fallito”
10 gennaio 2024: Alam Jahangir, 40 anni, originario del Bangladesh, si è impiccato con un pezzo di lenzuolo a Cuneo, pochi giorni dopo il suo ingresso
12 gennaio 2024: Fabrizio Pullano, 59 anni, si è impiccato nel padiglione di alta sicurezza del carcere di Agrigento
15 gennaio 2024: Andrea Napolitano, 33 anni. A Poggioreale per l’omicidio della moglie, soffriva di disturbi psichiatrici
15 gennaio 2024: Mahomoud Ghoulam, 38 anni, marocchino senza fissa dimora, era entrato da poco a Poggioreale
22 gennaio 2024: Luciano Gilardi, gli mancava un mese alla libertà ma è morto prima da detenuto a Poggioreale
23 gennaio 2024: Antonio Giuffrida, 57 anni, era in carcere a Verona Montorio per truffa
24 gennaio 2024: Jeton Bislimi, 34 anni, si è ucciso nel carcere di Castrogno a Teramo: musicista macedone, 34enne, aveva provato ad ammazzare sua moglie. Aveva già tentato il suicidio
25 gennaio 2024: Ahmed Adel Elsayed, 34 anni, è stato trovato dagli agenti impiccato nel bagno della sua cella a Rossano Calabro. Gli mancava poco per il fine pena
25 gennaio 2024: Ivano Lucera, 35 anni, si è impiccato nel carcere di Foggia. Soffriva di dipendenze
28 gennaio 2024: Michele Scarlata, 66 anni, si è ucciso nel carcere di Imperia pochi giorni dopo esserci entrato con l’accusa di avere tentato di uccidere la compagna
3 febbraio 2024: Alexander Sasha, ucraino di 38 anni, aveva già tentato di tagliarsi la gola prima di impiccarsi a Verona Montorio
3 febbraio 2024:Carmine S., detenuto disabile di 58 anni, si è impiccato nel carcere di Carinola (Caserta).
8 febbraio 2024: Hawaray Amiso, 28 anni, doveva scontare solo tre mesi a Genova. Invece avrebbe “manomesso la serratura del cancello della cella per ritardare l’intervento degli agenti di custodia” prima di impiccarsi
10 febbraio 2024: Singh Parwinder, 36 anni, bracciante agricolo, si è ucciso nel bagno del carcere di Latina
11 febbraio 2024: cittadino albanese, 46 anni, imprenditore. Si è ucciso a Terni. Gli erano state revocate da poco le misure alternative al carcere.
13 febbraio 2024: Rocco Tammone, 64 anni, era in semlibertà. Rientrato dal lavoro, si è ucciso nel cortile del carcere di Pisa
14 febbraio 2024: Matteo Lacorte, 49 anni, si è impiccato nel carcere di Lecce nel reparto di massima sicurezza. La Procura indaga per istigazione al suicidio
26 febbraio 2024: cittadino marocchino, 45 anni, si è impiccato a Prato
12 marzo 2024: Jordan Tinti, trapper, 27 anni, in carcere a Pavia per rapina aggravata dall’odio razziale. Aveva tentato il suicidio pochi mesi prima
13 marzo 2024: Andrea Pojioca, senza fissa dimora, 31 anni, ucraino. In carcere a Poggioreale per tentata rapina
13 marzo 2024: Patrck Guarnieri, è morto il giorno in cui compiva 20 anni per asfissia nel carcere di Teramo. Il pm indaga perché l’autopsia lascia dei dubbi che si sia trattato davvero di suicidio
14 marzo 2024: Amin Taib, 28 anni, tossicodipendente, si è ucciso nella cella di isolamento a Parma
21 marzo 2024: Alicia Siposova, 56 anni, slovacca, si è suicidata mentre era in corso una visita del cardinale Matteo Zuppi nel carcere di Bologna.
24 marzo 2024: Alvaro Fabrizio Nunez Sanchez, 31 anni, attendeva come molti l’ingresso in una Rems da alcuni mesi per gravi sofferenze psichiatriche. Invece si è ucciso nel carcere di Torino
27 marzo 2024: nigeriano, il nome non si sa, si è impiccato nel carcere di Tempio Pausania dove aspettava di essere processato per reati di droga.
27 marzo 2024: gli agenti lo hanno trovato appeso al cancello alle sei del mattino. Era da poco rientrato da un ricovero in ospedale, soffriva di disturbi psichici. Italiano, aveva 52 anni.
1 aprile 2024: Massimiliano Pinna, 32 anni, si è impiccato al secondo giorno di carcere a Cagliari dove era stato portato per un furto
7 aprile 2024: Karim Abderrahin, 37 anni, si è impiccato in cella a Vibo Valentia
10 aprile 2024: Ahmed Fathy Ehaddad, 42 anni, egiziano, attendeva l’inizio del processo per un caso di violenza sessuale nel carcere di Pavia
17 aprile 2024: Nazim Mordjane, 32 anni, palestinese, è morto inalando gas da un fornello da campeggio nel carcere di Como. Nel settembre dell’anno scorso era evaso ferendo un agente di polizia
22 aprile 2024: Yu Yang, 36 anni, si è impiccato attaccandosi alla terza branda del letto a castello a Regina Coeli
4 maggio 2024: Giuseppe Pilade, 33 anni, pativa disturbi psichiatrici e sarebbe dovuto stare in una Rems ma, come per la maggior parte di chi ci dovrebbe stare, non c’era posto per lui e si è tolto la vita nel carcere di Siracusa
16 maggio 2024: Santo Perez, 25 anni, si è impiccato nella sezione media sicurezza del carcere di Parma
23 maggio 2024: Maria Assunta Pulito, 64 anni, si è soffocata con due sacchetti di plastica annodati intorno alla testa e alla gola a Torino. Accusata di violenza sessuale assieme al marito, aveva sempre respinto le accuse
2 giugno 2014: George Corceovei, 31 anni, ha approfittato che due detenuti uscissero dalla cella che condividevano con lui per impiccarsi a Venezia
2 giugno 2024:Mustafà, 23 anni, si è impiccato nel carcere di Cagliari ma il suo corpo non ha ceduto subito. E’ morto due giorni dopo in ospedale
4 giugno 2024: Mohamed Ishaq Jan, pakistano, 31 anni. Da una decina di mesi aspettava di essere processato per lesioni e rapina a Roma Regina Coeli
11 giugno 2024: Domenico Amato, 56 anni, viene trovato impiccato alla mattina presto nel carcere di Ferrara. Con la sua morte, è stato osservato, lo Stato ha perso due volte perché era un collaboratore di giustizia e perché era nella custodia dello Stato
13 giugno 2024: A.L.B., italiano di 38 anni, si è tolto la vita nel carcere di Ariano Irpino impiccandosi alle otto della sera
14 giugno 2024: Alin Vasili, 46 anni, rumeno, si è impiccato nel penitenziario di Biella
15 giugno 2024: Giuseppe Santolieri, 74 anni, condannato a 18 anni per l’omicidio della moglie, si è ucciso nel carcere di Teramo soffocandosi con una corda. Lo aveva annunciato ai compagni di prigionia: “Non posso più andare avanti”
15 giugno 2024: un detenuto di 43 anni si è impiccato nel carcere di Sassari con un lenzuolo nel reparto ospedaliero
21 giugno 2024: Alì, un ragazzo algerino di 20 anni, si è impiccato nel carcere di Novara. “con un cappio rudimentale”, riferisce il sindacato della penitenziaria. Era detenuto per reati di droga
26 giugno 2024: Francesco Fiandaca di 28 anni che lavorava nella cucina ed era impegnato in diverse attività rieducative, si è impiccato nel carcere ‘Malaspina’ di Caltanissetta
27 giugno 2024: Luca D’Auria, un ragazzo di 21 anni, già sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, si è ucciso inalando gas nel carcere di Frosinone
27 giugno 2024: egiziano, 47 anni, era stato condannato per immigrazione clandestina. Si è impiccato con la cintura nel carcere genovese di Marassi.
1 luglio 2024: Giuseppe Spolzino, un ragazzo di 21 anni si è impiccato nel carcere di Paola. Nel maggio del 2027, a 24 anni, avrebbe potuto ricominciare, uscendo
2 luglio 2024: un uomo di cui non sono note le generalità si è ucciso nel carcere di Livorno a 35 anni
4 luglio 2024: Yousef Hamga, 20 anni, egiziano, si è impiccato nella casa circondariale di Pavia
4 luglio: nel carcere Sollicciano di Firenze si è tolto la vita il ventenne Fedi Ben Sassi. Poco prima di uccidersi, era saltata per mancanza di connessione una sua chiamata alla madre in Tunisia
7 luglio 2024: Vincenzo Urbisaglia, accusato dell’omicidio della moglie, si è ucciso a 81 anni nel carcere di Potenza. Ai legali era stata negata pochi giorni prima la scarcerazione chiesta per il suo stato psicofisico.
9 luglio 2024: Fabrizio Mazzaggio, 57 anni, si è impiccato nel bagno della sua cella a Varese. Aveva problemi di tossicodipendenza.
12 luglio 2024: Fabiano Visentini, 51 anni, si è ucciso a Verona Montorio
13 luglio 2024: un uomo di 45 si è suicida to a Monza chiudendosi la testa in un sacchetto di plastica nella cella dove stava da solo
15 luglio 2024: Alessandro Patrizio Girardi, 37 anni, detenuto per spaccio, si è impiccato nella sua cella nella casa circondariale Santa Maria Maggiore a Venezia dove stava per reati legati alla droga
21 luglio 2024: alla Dozza di Bologna si è tolto la vita Musta Lulzim, 48 anni, albanese. E’ stato trovato impiccato nella sua cella infuocata dall’estate.
25 luglio 2024: Giuseppe Pietralito, 30 anni, si è ammazzato in cella a Rebibbia dopo avere manomesso la porta per ritardare i soccorsi. Aveva saputo da poco che sarebbe uscito nel 2026, 4 anni prima del previsto perché gli era stata riconosciuta la continuazione dei reati. “Ma non ho un lavoro, nessuno crederà in me” aveva detto ai suoi legali.
27 luglio: ennesimo suicidio a Prato dove un giovane di 26 anni si è tolto la vita
28 luglio 2024: Ismael Lebbiati, 27 anni, fine pena previsto nel 2032, si è impiccato nel carcere di Prato dove nelle ore precedenti c’era stata una rivolta.
30 luglio 2024: Kassab Mohammad si è suicidato a 25 anni nel reparto isolamento del carcere di Rieti dov’era stato portato dopo i disordini del giorno prima.
3 agosto 2024: un recluso marocchino, 31 anni, senza dimora, si è impiccato nel carcere di Cremona
5 agosto: nel bagno del Tribunale di Salerno, dopo la convalida del suo arresto, si è ammazzato stringendosi un cappio al collo Luca Di Lascio, arrestato per codice rosso
5 agosto 2024: a Biella, A.S., albanese, 55 anni, stava facendo lo sciopero della fame perché aveva chiesto di essere trasferito in un carcere più vicino ai suoi familiari. Poi, si è ucciso
7 agosto: 35 anni, tunisino, si è tolto la vita impiccandosi con un laccio dei pantaloni nel carcere di Prato
15 agosto 2024: 36 anni, tunisino, avrebbe finito di scontare la pena per reati legati alla droga nel 2025. Si è impiccato nella sua cella di isolamento nel carcere di Parma dove era stato trasferito il giorno prima
29 agosto 2024: Saddiki aveva frequentato un corso da cuoco nel carcere di Reggio Emilia dove cucinando stava mettendo dei soldi da parte per i figli. Era altissimo, quasi due metri, si sarebbe impiccato con una maglietta alle grate della finestra
2 settembre 2024: Salvatore Borrelli, 62 anni, ex tossicodipendente, non aveva più rapporti con la famiglia. Si è impiccato nella cella della sezione isolamento del carcere di Benevento
5 settembre 2024: gli piaceva il profumo del pane che aveva imparato a fare nel carcere isolano di Gorgona dove lo infornava. Arrestato un anno prima per reati tributari, sembrava su una strada propizia. Invece V.G. si è tolto la vita a 56 anni, in permesso premio a casa della compagna.
5 settembre 2024: a Vincenzo Villani, 46 anni, mancavano pochi mesi da scontare. Alle 9 e 20 del mattino si è impiccato nella sua cella al primo piano della casa circondariale di Imperia
16 settembre 2024: John Ogais, 32 anni, si è tolto la vita nel carcere di Ariano Irpino nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza attiva per avere aggredito quattro agenti il giorno prima
17 settembre 2024: Salvatore Di Vivo, 50 anni, arrestato il 25 agosto per maltrattamenti in famiglia, alle 6 e 45 si è impiccato nella sua cella di Regina Coeli
4 ottobre 2024: l’ha trovato appeso alle sbarre di una cella un agente penitenziario. Era mattina e K.S, di cui si sa che aveva 24 anni ed era marocchino, l’avevano arrestato due giorni prima e portato al ‘Del Papa’ di Vicenza con l’accusa di stalking.
7 ottobre 2024: maghrebino, 40 anni, gli mancava anno da scontare. Si è impiccato alle otto della sera a Vigevano
12 ottobre 2024: alle 5 e mezzo del mattino, l’alba ancora acerba fuori, hanno trovato Pasquale De Mastro, 44 anni, detenuto per droga, strangolato coi lacci delle scarpe nel suo letto a San Vittore
22 ottobre 2024: Giuseppe Lacarpia aveva ucciso la moglie e con le sue mani ha stretto il nodo per impiccarsi nel carcere di Bari a 65 anni
28 ottobre 2024: il suicidio di Federico Librere, 57 anni, è arrivato inatteso, nel carcere lo descrivono come un detenuto “tranquillo”. Non è tranquillo il carcere: lui è il quinto a togliersi la vita in meno di un anno alla Dogaia di Prato.
4 novembre 2024: Vincenzo Bellafesta si stava liberando da uomo libero dalla droga ma per una sentenza di condanna dovuta a cumulo di pene per antichi furti e ricettazioni era tornato in cella a Santa Maria Capua Vetere. Di notte ha allungato un lenzuolo e se l’è stretto forte al collo.
5 novembre 2024: gli sarebbe bastato ‘scavallare’ l’anno perché a febbraio lo aspettava la libertà. Invece T.M,. marocchino, 41 anni, ha preso una cinghia, ha chiuso dietro di sé la porta della cella nel carcere di Venezia e tutto il resto che poteva venire.
15 novembre 2024: Ben Mahmoud Moussa, tunisino, 28 anni, prima di entrare a Marassi faceva il pizzaiolo ed era in cura per un disagio psichiatrico. Pochi giorni dopo esserci entrato si è impiccato. Non c’è stato tempo per la perizia psichiatrica chiesta dal suo legale.
21 novembre 2024: Benito Viscovo, 28 anni, è il quarto nell’anno a suicidarsi a Poggioreale. Impiccato con un lenzuolo. L’Ordine dei medici di Napoli parla di “mortificazione della vita umana” per le condizioni dei detenuti in questo carcere decadente che scoppia di persone
27 novembre 2024: “Occhi azzurri e il volto pulito”. La garante dei detenuti, Irma Testa, lo aveva incontrato pensieroso su una sedia, davanti alla finestra della cella a Cagliari pochi giorni prima del suicidio. Aspettava il nulla osta per andare in comunità. G.O. ha donato i suoi giovani organi, da tempo aveva lasciato scritto che avrebbe voluto finisse e iniziasse così
28 novembre 2024: Il cuore di Luca Zampini, 46 anni, ha smesso di battere 16 giorni in più di quanto avrebbe voluto. Ha atteso in ospedale dopo essersi impiccato nella cella di La Spezia. Avrebbe dovuto essere processato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.
6 dicembre 2024: “Aveva un sorriso triste e la morte negli occhi” ha detto il suo avvocato. Roberto Radion aveva tentato più volte di uccidersi e nemmeno l’ultima volta sembrava avercela fatta. E’ sopravvissuto per sei ore dopo essersi impiccato nel carcere di Montorio e infine ce l’ha fatta, chiudendo gli occhi a 24 anni.
16 dicembre 2024: Qualche giorno prima uno dei suoi compagni si era dato fuoco ed era stato salvato dagli agenti di Alessandria. Sempre loro avevano tenuto in vita Luca Lunardi dopo il tentativo di impiccarsi nel reparto ‘transiti’, dove i reclusi sono di passaggio. Il suo ultimo è stato in ospedale, dove è morto.
17 dicembre 2024: a mezzanotte, gli agenti che avevano appena cominciato il turno lo hanno trovato appeso alla finestra della cella del carcere di Viterbo. Il suo compagno di cella dormiva. Aveva 23 anni e il suo nome non è stato comunicato.
E se credete ora/che tutto sia come prima/Perché avete votato ancora/la sicurezza, la disciplina/Convinti di allontanare/ la paura di cambiare/Verremo ancora alle vostre porte/E grideremo sempre più forte/Per quanto vi crediate assolti/Siete per sempre coinvolti/Per quanto vi crediate assolti/Siete per sempre coinvolti/
p.s. tra le fonti di questo articolo ci sono comunicati della polizia penitenziaria, Ristretti Orizzonti, agenzie di stampa, testate nazionali e locali. grazie a tutti loro per avere dato dignità a queste morti, un compito che dovrebbe appartenere a uno Stato civile.